Ultimo banco 219. Passi da lumaca
A casa si torna, a scuola si va. La lingua, quando è madre, non mente. C’è casa infatti (anche a casa) dove e quando facciamo esperienza di appartenere alla vita senza dover dimostrare nulla (avere, fare, apparire). La vita è infatti un’odissea perché, come nel poema omerico, è un lungo ritorno a casa, dove chi ti ama ti riconosce mentre il mondo ti crede nessuno. A scuola invece si va, perché c’è scuola (anche a scuola) dove e quando scopriamo il modo che ciascuno ha di guardare e prendersi cura del mondo (campetto, oratorio, pianoforte, parco, bar… e tutte le altre scuole possibili). Casa non è “appartamento” (appartarsi) ma “appartenenza” (sentirsi voluti), scuola non è “edificio” (il muro dei Pink Floyd) ma “auspicio” (il futuro, la parola in latino indicava l’osservare il cielo per cogliere il volere divino nelle decisioni da prendere). Insomma casa è dove sempre posso essere, mi sento voluto nella vita, quindi ci torno; scuola è dove sempre porro incontrare la vita, mi sento chiamato, quindi ci vado. Dove al crescere dell’appartenenza cresce la libertà, è casa. Dove al crescere dell’incontro cresce l’individuazione, è scuola. Tornare a casa, essere, andare a scuola, crescere, sono i due movimenti dell’esistenza, a ogni età.
Dove torniamo o dove andiamo noi, oggi?
Ispirato dal filosofo Ivan Illich mi servo dell’immagine della lumaca che con la sua chiocciola “torna” e “va” al contempo. Crescendo secerne una sostanza calcarea con cui crea la conchiglia che fa da supporto agli organi e riparo dai predatori. Aggiunge una spira all’altra secondo la proporzione aurea (rapporto armonico presente in molti fenomeni naturali e imitato dall’uomo per esempio nelle misure di un tempio greco o della carta di credito), e si ferma quando un anello in più sarebbe sedici volte maggiore dell’ultimo, e la schiaccerebbe. La lumaca “torna” e “va” senza spezzare l’armonia tra dimensioni e bisogni, ciò che invece a noi accade oggi con l’eccesso di strumenti (dai dispositivi alle istituzioni) che invece di aiutarci a vivere ci opprimono, non riusciamo a “tornare” e ad “andare”.
Perché infatti pur avendo “strumenti” come mai accaduto nella storia, aumentano disuguaglianze, emergenze educative, patologie psichiche e disagi sociali? Perché la “chiocciola” ci schiaccia. Anche quella della casella (altra “casa”) mail: doveva semplificare il lavoro e invece la temiamo come i nostri antenati le fiere, uno studio ha infatti scoperto “le apnee” da apertura di posta elettronica, le stesse di chi, nella preistoria, tratteneva il fiato per affrontare animali feroci. Se uno strumento diventa un nemico non è più “salvifico”. Salvo (e salute) ha una radice antica che significa: integro, unito, tutt’uno. Uno strumento salva quando “integra” (unisce a sé e agli altri), al contrario “dis-integra” (separa da sé e dagli altri). Uno strumento salva quando estende/facilita l’azione personale senza rovinare la salute (ci rende più sani…) e le relazioni (…e salvi). Ciò vale per tutti i ritrovati culturali, dai dispositivi alle istituzioni.
La scuola salva se mi aiuta a diventare me stesso, se è una comunità di ricerca di adulti e giovani, se mi rende soggetto di possibilità e non oggetto di aspettative. La politica salva se facilita l’azione personale e sociale, altrimenti è solo gestione del potere e controllo burocratico. Un telefono salva se mi unisce al mondo non peggiorando la mia salute; se mi rende più autonomo, non dipendente; se facilita il sapere e non mi sfrutta a mia insaputa. Dove prevale la disintegrazione non c’è salvezza ma repressione. Questo oggi succede anche al corpo, non vissuto come “casa” (sono un corpo) ma come mezzo (ho un corpo) da rendere il più performante possibile (doping fisico e psichico) fino a bruciarsi (burn-out) o a crollare (depressione). Non si torna più a casa (dal corpo individuale a quello sociale), perché non si appartiene a niente e nessuno, come invece fa chi si lega ad altri per scalare senza sentirsi privato della libertà. Non si torna ma ci si intrattiene, cioè si è “trattenuti”, ognuno da solo col suo zaino sedici e più volte grande del necessario. Allo stesso modo si smette di andare a scuola: un sistema basato su precariato e burocrazia mortifica la relazione tra docenti e studenti e non serve certo a trovare se stessi incontrando il mondo.
Come dice splendidamente il filosofo spagnolo Esquirol nel recente La scuola dell’anima: “C’è casa perché ci sono le intemperie. E le intemperie richiedono protezione. C’è scuola perché c’è il mondo. E il mondo richiede attenzione. Ci sono casa e scuola perché, nella protezione e nell’attenzione, ognuno può percorrere la sua strada e maturare, per dare frutti. Che genere di frutti? Più casa e più mondo”. Da ciò che per ciascuno è tornare a casa o andare a scuola dipende cioè quanto siamo felici (felice è chi dà frutti).
Casa è per me incontrare il creato, come mi è successo qualche giorno fa camminando in un bosco in cui la luce umida del tardo pomeriggio trafiggeva l’intrico di abeti, pini e larici con lame luminose che, tagliando il denso pulviscolo verde, raggiungevano un sottobosco di cespugli, muschi e radici contratti dal sempre più silenzioso freddo autunnale. Uno di quei momenti in cui la bellezza mi contiene e il cuore è quindi “contento”, dal latino “contenuto”: mi sento figlio. Il contrario del “discontento”, cioè “non contenuto” (senza legami), espulso, separato, orfano, che provo in macchina nel traffico.
Andare a scuola è quando leggo pagine che lavano cuore e mente dall’abitudine, dal dato per scontato, dal pressapoco. Di recente mi è capitato con il De rerum natura (La natura delle cose) di Lucrezio magistralmente tradotto dal poeta Milo De Angelis. Un’immagine mi ha aperto gli occhi (dormiamo anche da svegli?): il poeta latino Ennio immagina di ricevere la sua vocazione poetica nell’aldilà, da Omero. Il poeta greco rivela a quello latino la natura di tutte le cose, ma lo fa in lacrime. È l’essenza della scuola: trovare la nostra vocazione grazie a un maestro, che ci indica sia che la vita finisce (è limitata) sia che è un miracolo inesauribile (ci chiama), con lacrime rispettivamente di dolore e di gioia. Una pagina così mi fa incontrare il mondo e trovare me stesso, perché è solo la verità che rende liberi.
Insomma casa e scuola ci accadono quando, una volta scoperto dove si trovano per noi, vivere diventa moltiplicare ritorni e andate, per fare più casa e più mondo. E se troviamo ostacoli o distrazioni, da lì deve cominciare l’azione, per rimuoverli. Se abbiamo costruito una spira di troppo, non serve dividersi tra apocalittici (il cellulare è morte!) e entusiasti (il cellulare è vita!), ma discernere caso per caso, eliminando, in ogni strumento (dispositivo o istituzione), il troppo, e custodendo il necessario.
Per tornare a casa e andare a scuola non servono passi da gigante, ci vogliono passi da lumaca, quando andare e tornare sono un unico movimento, verso la gioia.
Corriere della Sera, 12 novembre 2024 – Link all’articolo e ai precedenti


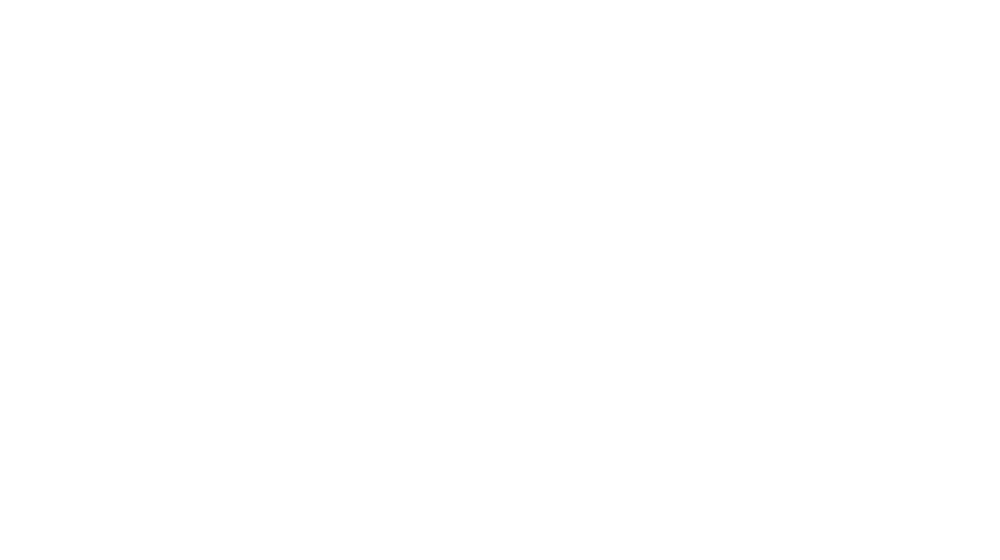
Salve, sono Federica Salvan, già comparsa sovente con umili contributi.
Certamente, la scuola, educazione autentica se impara a narrare me stesso/ssa, se mi rapporto, relaziono con la comunicazione onesta e luminosa. Se poi, soprattutto, sollecito a comprendere che cosa sia quel dispositivo che afferro in cui cerco un game da condividere con altri.
Ancora la scuola diventa comunità nella comunicazione ,in cui si scopre chi si è, che nessuno è inferiore, da poco, ma conta, vale nel suo essere.
Così, si è contenti, non scontenti, contenuti nella mia persona, che si stupisce nel percorso, tappa dopo tappa e, soprattutto segue una intelligenza critica.
E’ il passo da lumaca che piano piano procede come il mio incedere che per affezione fisica, anche su carrozzina , va piano, ma anche nel sentire che si ferma ed ascolta.
Federica
Buongiorno a tutti. Io vorrei fare un paio di considerazioni: io sono tra quelli che sostengono di avere (e non di essere) un corpo, perché il mio non è mai stato da normodotato. Questa mia esperienza di vita terrena, mi ha fatto capire che oltre al corpo c’è qualcos’altro: mente, anima e spirito, per esempio. Nonostante io descriva il mio corpo, da sempre, come una vecchia carriola arrugginita, con la ruota perennemente sgonfia, cerco di scarteggiare la ruggine, di tenere in ordine il tutto, grazie alla fisioterapia.
Per quanto riguarda il telefonino: dal mio ho tolto tutte le notifiche, nonostante le varie app (così si chiamano ora) mi suggeriscano in continuazione di inserirle. Sono io a usare lo smartphone e non viceversa. Mi irritano tutti quei bip bip e bip bop (suoni vari) che mi avvisano ogni secondo di qualcosa. Per me lo scritto (che si tratti di cartaceo, pc o smartphone) non è sinonimo di urgenza. Chi ha urgenza mi può telefonare. Forse ragiono così perché ho quasi 66 anni?
Caro Fabrizio, credo che ragioni così perché sei un uomo libero e sai come difenderti da strumenti troppo invasivi, cosa che non tutti sono capaci di fare. Quanto al discorso del corpo grazie per la tua precisazione, quando dico che siamo un corpo è solo per ribadire qualcosa che oggi non ricordiamo più, e cioè che spirito e corpo sono un’unica cosa e che la loro forzata separazione è fonte di incomprensione e sfruttamento. QUell’essere un corpo non significa che siamo solo un corpo, ma che il corpo è il luogo del nostro essere del mondo e non un oggetto da rendere a tutti i costi performante. Un abbraccio e grazie