Ultimo banco 119. La porta
Una coppia con un bimbo cambia casa, ma arrivati a destinazione trovano solo la porta. Marito e moglie cominciano a litigare: il primo, sognatore, sostiene che la casa è lì, la moglie, realista, non è della stessa idea, non si sa neanche dove sia il dentro e dove il fuori. Poi, dalla porta, cominciano a uscire (o entrare?) bizzarri personaggi che animano la vita della famiglia.
È la trama di una divertente favola moderna dello scrittore portoghese José Fanha, dal titolo La porta, che ho letto da poco. Una collaboratrice scolastica del mio Istituto, grata per i miei libri, mi ha cercato e mi ha detto che quella storia, che lei legge regolarmente con i figli, era il suo modo di ringraziarmi. Ho lasciato il piccolo libro sul comodino, nella colonna «libri che leggerò presto ma al momento giusto», poi una sera in cui avevo bisogno di gioia, ho cominciato a leggerlo e sono stato catapultato nel mondo delle favole in cui l’essenziale è rivelato attraverso il realismo simbolico.
Qual è il fondamento di una casa? La porta, confine tra dentro e fuori, tra chi entra e chi esce, tanto che per gli antichi romani esisteva un dio custode delle porte e il termine per porta (foris, da cui i fori romani, porte di ingresso e non buchi delle rovine, come credeva un mio alunno) indicava la soglia tra «fuori» (che viene appunto da foris) e dentro (la casa): chi viene da «fuori» è infatti forestiero, uscito dalla foresta, spazio pericoloso dal quale ci salva la porta di casa. Ma quale casa?
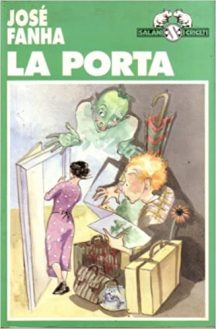 Le favole sono piene di porte speciali, perché anche nella realtà ogni porta lo è, e la favola portoghese mi ha ricordato che casa è dove c’è una soglia che consente la relazione tra me e il mondo. Se apro la porta, cioè sono disponibile ai forestieri, succedono cose interessanti, prima di tutte: la casa si amplia. Anche la scuola è fatta di porte in cui non si sa bene quale sia il dentro e quale il fuori, perché le relazioni autentiche con gli studenti, pur mantenendo l’asimmetria educativa, comportano non solo il nostro ingresso nel loro mondo, ma anche il contrario. Ogni classe è una porta, che fa della relazione educativa non un’emorragia di esistenza che sfinisce il docente, ma una moltiplicazione delle stanze della sua casa: più lascio entrare più la casa diventa grande. A tal proposito vorrei raccontare due episodi che in quest’anno scolastico mi hanno segnato. A dicembre i due rappresentanti della classe terza di cui sono coordinatore mi hanno chiesto un colloquio. Credevo avessero qualche problema o proposta a nome della classe, ma hanno esordito così: «Dall’inizio di quest’anno lei è cambiato, la nostra relazione con lei è peggiorata. Volevamo capire: se dipende da noi, che cosa possiamo fare; se invece dipende da lei, come esserle d’aiuto». Sono rimasto in silenzio per trattenere la commozione. Ho poi spiegato loro che stavo attraversando un periodo difficile e faticavo a farmi carico di loro alla maniera di sempre. Non ho esplicitato i motivi, li ho ringraziati e ho detto loro che quella attenzione era la cosa migliore che potessero fare e che loro, a differenza di tanti adulti, non erano rimasti indifferenti. La porta era stata varcata e la relazione (casa) ampliata. A gennaio, al ritorno dalla pausa natalizia, un’alunna mi ha poi chiesto: «Ma lei come sta?». Li ho abituati a ritenere questa domanda la più seria al mondo e a disporsi ad ascoltare veramente la risposta (è infatti la stessa domanda di un medico al paziente). E così le ho risposto che continuava il periodo difficile. Quello stesso pomeriggio mi ha mandato la foto di un passo dell’Odissea (l’abbiamo letta integralmente al primo anno) con gli appunti presi durante la lezione. Vi si narra il momento in cui Circe spiega a Ulisse che per tornare a Itaca deve prima andare nel mondo dei morti e invocare Tiresia, il profeta che gli svelerà l’esito del viaggio. Circe dopo aver descritto quanto triste sia la condizione dei morti, raccomanda all’eroe di non attardarsi tra loro: «Ma tu torna presto alla luce!» erano le parole che la studentessa aveva sottolineato per me. Accanto, a matita, c’erano gli appunti presi durante quella lezione in cui spiegavo che a Ulisse è concesso di vivere la morte in anticipo ma senza morire, e proprio per questo potrà poi affrontare la vita con coraggio. La ragazza mi richiamava alle mie stesse parole, invitandomi a tornare alla luce e incoraggiandomi a non aver paura di «quella morte» che era solo una tappa necessaria per rinascere a una vita più autentica. Nel messaggio, alla foto del passo dell’Odissea si accompagnavano poche parole essenziali: «Le auguro di poter stare presto meglio, in ogni caso io e i miei compagni siamo presenti», esattamente quello che chiediamo loro ogni mattina al momento dell’appello. Ma non un «presente» burocratico utile solo al registro, ma il «presente» che risponde alla vita in prima persona e solo così rende la vita un vero «presente». Questi ragazzi sanno farsi carico del mondo e degli altri, e questo è l’aspetto più importante della crescita di un adolescente soprattutto in una cultura intrisa di individualismo: solo chi ha uno sguardo «presente» sul mondo ne diventa responsabile (aggettivo che viene da rispondere), cioè capace di prendersene cura.
Le favole sono piene di porte speciali, perché anche nella realtà ogni porta lo è, e la favola portoghese mi ha ricordato che casa è dove c’è una soglia che consente la relazione tra me e il mondo. Se apro la porta, cioè sono disponibile ai forestieri, succedono cose interessanti, prima di tutte: la casa si amplia. Anche la scuola è fatta di porte in cui non si sa bene quale sia il dentro e quale il fuori, perché le relazioni autentiche con gli studenti, pur mantenendo l’asimmetria educativa, comportano non solo il nostro ingresso nel loro mondo, ma anche il contrario. Ogni classe è una porta, che fa della relazione educativa non un’emorragia di esistenza che sfinisce il docente, ma una moltiplicazione delle stanze della sua casa: più lascio entrare più la casa diventa grande. A tal proposito vorrei raccontare due episodi che in quest’anno scolastico mi hanno segnato. A dicembre i due rappresentanti della classe terza di cui sono coordinatore mi hanno chiesto un colloquio. Credevo avessero qualche problema o proposta a nome della classe, ma hanno esordito così: «Dall’inizio di quest’anno lei è cambiato, la nostra relazione con lei è peggiorata. Volevamo capire: se dipende da noi, che cosa possiamo fare; se invece dipende da lei, come esserle d’aiuto». Sono rimasto in silenzio per trattenere la commozione. Ho poi spiegato loro che stavo attraversando un periodo difficile e faticavo a farmi carico di loro alla maniera di sempre. Non ho esplicitato i motivi, li ho ringraziati e ho detto loro che quella attenzione era la cosa migliore che potessero fare e che loro, a differenza di tanti adulti, non erano rimasti indifferenti. La porta era stata varcata e la relazione (casa) ampliata. A gennaio, al ritorno dalla pausa natalizia, un’alunna mi ha poi chiesto: «Ma lei come sta?». Li ho abituati a ritenere questa domanda la più seria al mondo e a disporsi ad ascoltare veramente la risposta (è infatti la stessa domanda di un medico al paziente). E così le ho risposto che continuava il periodo difficile. Quello stesso pomeriggio mi ha mandato la foto di un passo dell’Odissea (l’abbiamo letta integralmente al primo anno) con gli appunti presi durante la lezione. Vi si narra il momento in cui Circe spiega a Ulisse che per tornare a Itaca deve prima andare nel mondo dei morti e invocare Tiresia, il profeta che gli svelerà l’esito del viaggio. Circe dopo aver descritto quanto triste sia la condizione dei morti, raccomanda all’eroe di non attardarsi tra loro: «Ma tu torna presto alla luce!» erano le parole che la studentessa aveva sottolineato per me. Accanto, a matita, c’erano gli appunti presi durante quella lezione in cui spiegavo che a Ulisse è concesso di vivere la morte in anticipo ma senza morire, e proprio per questo potrà poi affrontare la vita con coraggio. La ragazza mi richiamava alle mie stesse parole, invitandomi a tornare alla luce e incoraggiandomi a non aver paura di «quella morte» che era solo una tappa necessaria per rinascere a una vita più autentica. Nel messaggio, alla foto del passo dell’Odissea si accompagnavano poche parole essenziali: «Le auguro di poter stare presto meglio, in ogni caso io e i miei compagni siamo presenti», esattamente quello che chiediamo loro ogni mattina al momento dell’appello. Ma non un «presente» burocratico utile solo al registro, ma il «presente» che risponde alla vita in prima persona e solo così rende la vita un vero «presente». Questi ragazzi sanno farsi carico del mondo e degli altri, e questo è l’aspetto più importante della crescita di un adolescente soprattutto in una cultura intrisa di individualismo: solo chi ha uno sguardo «presente» sul mondo ne diventa responsabile (aggettivo che viene da rispondere), cioè capace di prendersene cura.
Chi non è «presente» non può «rispondere»: la porta è chiusa, la casa non ha ancora stanze, come quella all’inizio della favola, in cui c’è solo la porta e la casa si costruisce nella misura in cui si ospita e si è ospitati. Nel linguaggio ordinario non usiamo forse l’immagine della porta proprio per indicare momenti «chiave» della vita: «ha aperto la porta del mio cuore». Il centro del nostro essere ha una porta che scegliamo noi a chi aprire e questo costruisce la nostra identità e amplia lo spazio interiore: amare è aprire porte.
Nella poesia greca e latina c’era un vero e proprio genere letterario noto come «canto fuori dalla porta», in cui l’amato cerca di convincere l’amata ad aprire. Nella Bibbia il motivo diventa simbolo dell’incontro con Dio, dal Cantico dei cantici in cui il corpo è la porta dell’amore: «Mi sono addormentata, ma veglia il mio cuore. / Un rumore! La voce del mio amato che bussa: / “Aprimi, sorella mia, / mia amica, mia colomba, mio tutto; / perché il mio capo è madido di rugiada, / i miei riccioli di gocce notturne”. / L’amato mio ha introdotto la mano nella fessura / e le mie viscere fremettero per lui. / Mi sono alzata per aprire al mio amato / fluiva mirra dalle mie dita / sulla maniglia del chiavistello», fino all’Apocalisse in cui è Cristo stesso che bussa al cuore di ognuno: «Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3,20).
Insomma aprire una porta o lasciare che qualcuno la apra per noi è decidere chi vogliamo essere, e tutte le porte che apriamo configurano la nostra casa nel mondo. Anche a scuola l’essenziale non sono i muri, ma le porte, le relazioni autentiche con gli altri: da una collaboratrice scolastica che presta un libro per dire grazie, a studenti che prestano attenzione a un insegnante per alleviarne la fatica, passando per uno scambio di auguri pasquali organizzato dai genitori degli studenti di una classe per rivedersi in viso dopo mesi di schermi. Aprire una porta è creare una casa, ma per aprire una porta bisogna fare un passo indietro, cioè fare spazio, però quando lo si fa la casa acquista una stanza in più, come fosse un corpo vivo, come accade con le porte delle favole, cioè nella realtà. A chi aprirete oggi? Oggi chi vi aprirà la porta?
Corriere della Sera, 9 maggio 2022 – Link all’articolo e ai precedenti





Il film horror «Non aprite quella porta» dà un avvertimento che riprende in sostanza tutti i guai, le inondazioni di guai, che capitano in molte favole quando si aprono delle porte. Il lupo travestito da cappuccetto rosso apre la porta di casa della nonna, i sette capretti aprono al lupo camuffato da mamma capra, Hansel e Gretel entrano nella casa della strega incantati dalla casa costruita con biscotti e dolci. Come le favole dei fratelli Grimm insegnano, la porta non si può aprire a tutti. Forse la questione più importante della vita è capire di chi ti puoi fidare, cogliere i segni, interpretare i gesti, conoscere e riconoscere le persone. Non è facile, perché alcune persone portano maschere, come i lupi delle favole. Alcune le portano intenzionalmente e vogliono fare male, altri invece portano la loro maschera e non lo sanno neanche, ma i danni li fanno comunque, a loro stessi e anche agli altri. Per aprire è importante fare quindi un lavoro sulla fiducia, e per livelli accogliere prima rispondendo solo al citofono, poi aprendo la porta e rimanendo sulla soglia. Poi si entra nella zona giorno, in anticamera e in seguito in salotto. Il tempo è ciò che ci vuole, tempo da dedicare alle relazioni, perché la fiducia è una questione di tempo e col tempo si costruisce lo spazio delle stanze della zona notte, e la casa diventa grande. C’è sempre però il fattore R, il rischio, da questo gioco non si può eliminare. Può capitare infatti che la stanza si era formata ma poi viene abbandonata, lasciata lì, vuota, buia e fredda. Allora si chiude la porta di quella stanza, si mettono i nastri a X e il cartello “Area inagibile” e si sta altrove, nelle stanze abitate con la luce e il riscaldamento. Questi incidenti di percorso alla fine non sono un male, va bene così, perché anche dai lupi si può imparare. La fiducia si può imparare non solo da quello che è, ma anche da quello che non è.