Ultimo banco 52. Gli amortali
I morti hanno a che fare con i vivi: l’ho imparato sin da bambino. Nella notte tra l’1 e il 2 novembre, nella mia Palermo, la tradizione voleva che fossero i defunti a portare regali, tra questi i caratteristici «pupi di zucchero». Poi nel multicolore freddo autunnale si andava al cimitero.
I Greci lo chiamavano necropoli, città dei morti, convinti che dopo la morte diventiamo ombre che si aggirano in una incolore e triste imitazione della vita. Opponevano quindi la solidità delle case-tomba all’oblio: la pietra, fissando il nome, consentiva all’individuo di non sparire del tutto. In fondo erano loro ad aver dato agli uomini il nome del loro destino: «i mortali». Sapere di essere tali era l’origine dell’amore per la vita e quindi della creatività della cultura, che è infatti ciò che l’uomo di ogni epoca oppone alla morte. La morte ci costringe a definire ciò che per noi ha veramente valore. Per loro la morte era anonimato e oblio, e strappare un individuo a queste forze era strapparlo alla morte: l’eroe la sconfiggeva facendosi un nome eterno. Meglio una vita breve ma memorabile che lunga e anonima: in questa scelta c’è tutta la storia greca da Achille ad Alessandro Magno.
Poi arrivarono i cristiani e preferirono la parola «cimiteri», perché il cadavere era solo la scorza di un seme nato a nuova vita. Cimitero significa infatti giaciglio come la terra è il letto del seme: la morte è solo il passaggio dal seme al germoglio. Ogni sera noi «moriamo» un poco mettendoci orizzontali, ma è una morte che porta la vita attraverso il riposo.
D’altronde erano stati proprio i cristiani a cambiare il modo di indicare gli uomini, tra loro si chiamavano «i viventi», non più i mortali. Sapevano che c’era la morte, ma era solo un «sonno». Anche per la cultura cristiana l’esistenza acquisiva così pieno slancio, perché era il luogo e il tempo in cui la Vita che non muore germoglia in chiunque voglia accoglierla: «Sono venuto perché gli uomini abbiano la vita e la abbiano in abbondanza» dice Cristo.
Se l’eroe antico mostra ciò che l’uomo può fare con le sue forze, il santo (l’eroe cristiano) mostra ciò che Dio può fare nell’uomo. In entrambe le visioni, pagana e cristiana, la morte è così presente che genera un effetto creativo e propositivo sulla vita terrena: passione, ricerca, impegno… I «mortali» per guadagnare l’immortalità, i «viventi» per riceverla in dono.
E noi oggi che rapporto abbiamo con i morti e quindi con la morte? Ci sono rimasti Halloween e gli zombie dei film, perché abbiamo scelto di considerare la morte la debolezza di un’umanità arcaica e immatura.
Per noi progrediti la morte non esiste più. Ma che riflesso ha questo sulla vita?
Siamo cresciuti in una cultura di soddisfazione del desiderio ed ebbrezza tecnica senza precedenti. Ci sentiamo liberi: ciò che è permesso e ciò che è possibile non hanno o non avranno presto più confini, libertà e progresso sono per noi un tutt’uno.
Poi, all’improvviso arriva il virus, e l’illusione si sgretola: la morte torna reale, vicina, e la paura ha il sopravvento sulla razionalità e l’azione.
La parola paura ha la stessa radice di pavimento. Paveo (in latino: ho paura, da cui pavido e impavido) in origine indicava «l’esser percossi». La paura colpisce il corpo come i passi il suolo. Amo questa strana e antica parentela tra paura e pavimento: il timore ci costringe a puntare i piedi e scoprire su cosa abbiamo costruito.
La paura sta mettendo alla prova le fondamenta del nostro vivere: il pavimento della nostra vita.
Se camminavamo sulle sabbie mobili affonderemo, ma dalle sabbie mobili si esce aggrappandosi a un elemento esterno e stabile. Il virus ci sta obbligando a cercarlo, ricordandoci che la morte c’è ancora e che la soddisfazione di ogni desiderio unita al progresso senza limiti non bastano per essere felici.
La rimozione della morte ci ha reso come bambini che vanno incontro a prese elettriche e finestre aperte come fossero divertimenti. Abbiamo deciso di far finta che la morte non esista: l’abbiamo rimossa dal nostro vissuto quotidiano. Ulisse, Enea, Dante per trovare/tornare a casa devono prima incontrare i morti. Noi i morti li abbiamo fatti sparire.
Ma la morte resta lì, limite invalicabile della vita e suo paradossale appello. Senza la consapevolezza e l’accettazione della morte, che crediamo o no nell’aldilà, non si può essere innamorati della vita: l’uomo crea, ri-crea e pro-crea per non morire.
L’uomo «a-mortale» di oggi invece spesso«de-crea», cerca la sicurezza, rischia ben poco e quindi non evoca le energie che moltiplicano la vita, che è per lui un oggetto fragilissimo da proteggere da ogni «colpo», da ogni «paura». Ma così si perde il gusto di vivere, perché la vita non è un oggetto ma la ricerca che i vivi conducono per trovare un antidoto alla morte: che cosa è più forte della morte?
Essere a-mortali impedisce di trovare la risposta, perché tutto il coraggio per vivere dipende dal saper morire.
Corriere della Sera, 2 novembre 2020 – Link all’articolo e ai precedenti


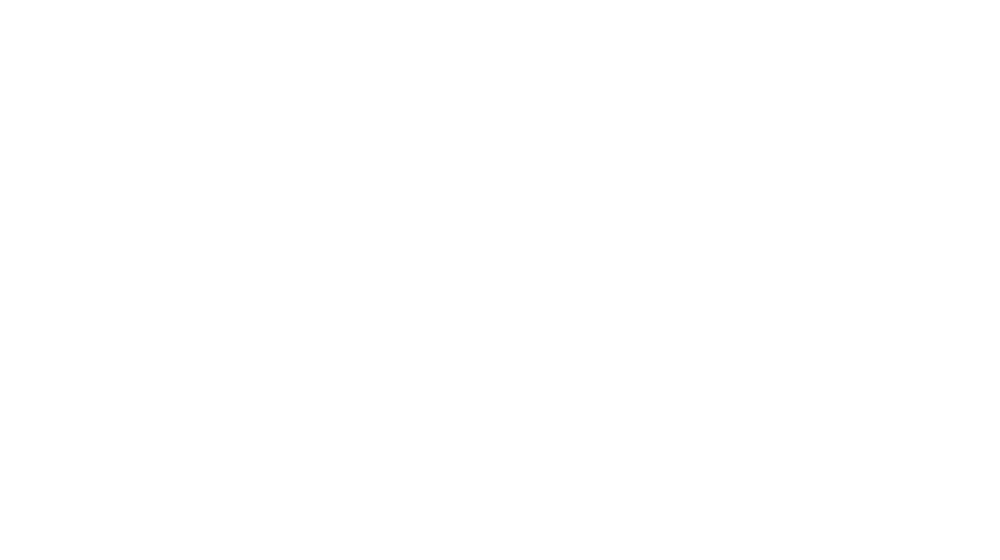
A mio parere, uno dei problemi della nostra società è quello di rifiutare la vecchiaia.
Nel nostro mondo, che si definisce progredito, non c’è spazio per gli anziani che, se malati, spesso vengono lasciati negli ospizi, perché sono un “peso gravoso”.
Nella nostra società, gli anziani sono un peso perché fuori dal circuito lavorativo, quindi dalla produttività.
La nostra è davvero una società amor(t)ale perché esistono solo produttori e consumatori… Le persone non esistono, soprattutto se fragili, malate, anziane.
È un problema socio-culturale, perché ci sono dei popoli che considerano gli anziani delle vere e proprie fonti di saggezza. Paesi dove vige la gerontocrazia e l’anziano è governante.
Invece, la nostra società subisce l’effetto “lifting”, o effetto levigatezza (come descriveva in uno dei suoi artico articoli).
La nostra società ha paura delle rughe, forse perché ha paura della vita e della vita vissuta.
Si fa di tutto per nasconderle, perché sono “antiestetiche”, mentre la società persegue ciò che è “antietico”.
La nostra società viene definita società di “Peter Pan”, non perché non vuole maturare, ma perché ha paura di invecchiare.
Per questo è profondamente immatura.
Trovo un collegamento tra questo e la paura/rifiuto della morte, della sofferenza, della malattia.
La nostra società non giungerà a maturazione fino a quando non accetterà le componenti scomode della vita.
Come scrive lei nel libro “L’appello” : “l’importante è non trasformare le persone in problemi”.
È proprio questo che fa la nostra società : trasforma le persone fragili o malate in problemi.
Come possiamo coltivare “l’arte di pensare o educarci alla morte”, se prima non coltiviamo “l’arte di educarci alla vecchiaia”?
Guardando meglio la copertina del suo libro, ho visto le cinque file di fiori che escono dal vaso come se fosse una mano pronta a rispondere all’appello.
Forse, è anche un appello a coltivare proprio le componenti della vita che ci fanno paura, come la vecchiaia, la sofferenza, la malattia, la morte.
Noi viventi siamo “una matita nelle mani di Dio” e la bellezza della vita sta nel vedere quali magnifici doni Dio realizza per tutti noi, suoi amati figli. La morte è la fine della nostra vita terrena ma noi sin dal battesimo viviamo una seconda vita in Dio e quella è eterna.
Possiamo tranquillamente sacrificare la nostra vita terrena visto che l’ altra, quella più bella è eterna.
Caro Alessandro, sono felice della pubblicazione di questa tua ultima fatica letteraria. Lo comprerò presto e spero di poterne regalare anche qualche copia. Bellissima la tua intervista su libraio.it. Spero che dal romanzo venga tratto, presto, anche un film. Vedrei bene come regista Gennaro Nunziante. Lui è uno che ha molta fiducia nelle nuove generazioni, come si evince dal film “Il Vegetale” del 2018.