Letti da rifare 46. Captorix

Il suo lavoro è ripetitivo e inutile, l’amore un divertimento sessuale vuoto, il tempo una catena di montaggio del consumo: a 46 anni non ha ragioni né per vivere né per morire. L’unica speranza per Florent-Claude Labrouste è il Captorix, una pillola che lo protegge dalla depressione e garantisce un apatico benessere. Il farmaco, attutendo le emozioni, è in grado di disattivare il desiderio di felicità e quindi di prevenire l’angoscia dell’insoddisfazione. È la descrizione del protagonista di Serotonina, ultimo romanzo di Michel Houellebecq. Patologo compiaciuto del disincanto occidentale, rovista sadicamente e in modo spesso ripugnante nel cadavere dell’uomo contemporaneo. Ma se è vero che il desiderio infinito di felicità, risolto in infinito consumo, alla prova dei fatti è morte in vita, proviamo ad andare oltre la disperata ma utile intuizione del libro. L’uomo moderno ha posto il suo principio vitale nel «risultato»: la felicità sta nella produzione di se stesso e del mondo e l’io, (iper)teso verso qualcosa che deve sempre arrivare, è sospeso nel vuoto angosciante dell’auto-realizzazione. L’eroe dell’epopea del risultato è l’in-dividuo (traduzione di a-tomo: ciò che non può essere diviso): non avendo significato in sé deve produrlo, essere «abbastanza» per procurarsi un io, per «realizzarsi», diciamo, tradendo il fatto che altrimenti pensiamo di essere «irreali». Questo meccanismo genera un io perennemente in-soddisfatto, negazione di «satis-facere»: fare abbastanza. L’io resta sempre al di qua dell’abbastanza necessario a raggiungere gli standard imposti dalla cultura per essere considerati «reali», cioè vivi. Il Captorix è la cura al continuo naufragio del desiderio infinito di felicità, disattivare l’infinito a favore delle procedure è l’unico modo di non disperarsi: «Non dà alcuna forma di felicità, e neppure di vero sollievo… trasformando la vita in una serie di formalità, aiuta a vivere, o almeno a non morire».
Oggi educhiamo, spesso inconsapevolmente, a questo individualismo insoddisfatto. Vedo bambini spinti a correre l’uno contro l’altro, a con-correre, anziché stare nel gioco della vita in squadra. Vengono caricati di ansia per i compiti e di una competitività eccessiva nelle attività extrascolastiche, in cui a trionfare sono i genitori più che i figli, usati come trofei. I crescenti disturbi di attenzione mi sembrano ribellioni alla morsa del risultato: per essere felice «devi funzionare». Lo stesso accade a molti adolescenti che, nell’età della scoperta della propria unicità da portare nel mondo, rivolgono la loro energia, privata delle radici dell’accettarsi così come si è, contro se stessi: il suicidio è la seconda causa di morte sotto i 20 anni e preoccupa la crescita esponenziale di disturbi psichici, oltre al consumo di alcool e sostanze, non da ultima l’eroina, divenuta accessibile ai giovanissimi nella versione «gialla», facilmente reperibile a poco prezzo. La logica del risultato come senso ha un esito tragico sulle vite, o si lotta fino a sfinirsi o ci si ritira, già sfiniti, come scrive Houellebecq: «La morte finisce per imporsi, il processo di disfacimento è più rapido per quelli che non hanno mai fatto parte del mondo, non hanno mai ipotizzato di vivere, né di amare, né di essere amati; quelli che hanno sempre saputo che la vita non era alla loro portata».
La causa è nella rinuncia alla persona in favore dell’individuo, alle relazioni costitutive dell’io a favore della sua auto-promozione. A scuola siamo più preoccupati di finanziare l’introduzione di test standardizzati che far fiorire l’unicità dei ragazzi. In politica il consenso elettorale prevale sull’azione effettiva per facilitare la vita e l’iniziativa dei cittadini. Nell’informazione si distorce la verità per manipolare l’opinione pubblica e ottenere click. Ossessionati in tutto dai risultati sentiamo un angoscioso e ingiustificato senso di inadeguatezza alla vita. Eppure tutti speravamo nella salvezza del piccolo Julen caduto nel pozzo: 300 operai hanno rimosso per 13 giorni di seguito 100 mila tonnellate di terra, perché una sola vita merita ogni sforzo. Nelle situazioni limite emerge il fatto che siamo convinti che la vita è nella cura della persona: Julen è diventato figlio di tutti e nessuno ha pensato che quell’impegno fosse un inutile spreco di risorse. Il diamante non ha la stessa origine del carbone? Ma proprio il tempo e le condizioni attorno hanno permesso di trasformare in bellezza la stessa base materiale. La vita acquista energia e raggiunge la sua bellezza grazie alle relazioni in cui è immersa nel tempo. Solo una cultura della persona, a correttivo di quella del risultato, può liberare e compiere la vita.
Il cristianesimo, ridotto oggi a pratica esangue o sentimentalismo privato, aveva donato qualcosa di assolutamente nuovo e vitale al mondo antico: la persona. Cristo è il Figlio del Padre, la sua identità divina non è individuale ma relazionale, è un figlio, cioè il suo modo di essere Dio e uomo è essere figlio: la condizione umana trova pienezza e compimento nel ricevere la vita, non nel «procurarsela», nell’accoglierla, non nel «produrla». Un figlio amato non ha paura di vivere, anche quando è debole, fallisce, cade, perché riceve tutto dal padre che dà la vita: «Sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» dice infatti Cristo. L’individuo invece ha paura, perché è un orfano, solo contro tutti deve lottare per essere accettato e potersi poi accettare. L’individuo deve generarsi da solo, la persona è generata dalle relazioni. Ma gli individui non esistono, esistono figli perché in relazione con genitori; esistono amici perché in relazione con amici; esistono mariti e mogli perché in relazione con il coniuge; esistono discenti perché in relazione con docenti… L’io, grazie alle relazioni sane, è donato al mondo e a se stesso, non deve auto-promuoversi né meritarsi di vivere, è già «abbastanza»: quindi dalla qualità di queste relazioni nel tempo dipende il suo fiorire. Se però esse sono improntate solo al risultato l’io si sente sempre in-adeguato e in-soddisfatto, perché è voluto (bene) solo se all’altezza, il tu non è accolto così com’è, ma solo così come deve essere, secondo certe aspettative e certi standard. Invece la persona è già all’altezza, e per questo, nel singolo compito, può riuscire o fallire, senza paura che venga meno la sua esistenza e consistenza. La persona non si deve «realizzare», è già «reale» anche se incompiuta, e la sua incompiutezza non è una colpa, ma una energia interna attivata dalle relazioni, per diventare «più» reali. Grazie all’amore la persona riceve se stessa in «dono» ed è rinnovata nel «per-dono», il suo essere riposa nell’amore, invece l’individuo deve porre e imporre se stesso, non riposa mai.
Dobbiamo invertire, in famiglia e a scuola, la priorità della prestazione sulla presenza, ristabilendo il primato di quest’ultima. Vedo genitori, soprattutto mamme, angosciati dall’iscrizione alla prima elementare più di quanto si preoccupino di curare l’armonia tra intelligenza e affettività dei propri bambini. Si punta tutto sulle competenze, dimenticando che la persona è armonia sinfonica delle componenti vitali: spirito, intelligenza, volontà, corpo. Le domande dopo scuola (se non durante con messaggi invasivi) sono: com’è andata? Sei stato interrogato? Che voto hai preso? Che compiti devi fare? Nel parlare dei figli chiedono se sono bravi, non se sono felici, che cosa fanno, non chi sono. Il risultato è tutto. I figli, non riuscendo a sostenere la pressione, implodono o esplodono, o comunque interiorizzano che «essere non è esserci, ma riuscire». Basterebbe cominciare a sostituire le domande di prima: come stai? Avete giocato? Che cosa avete scoperto di bello? Con chi hai fatto amicizia? Come sta la maestra? Curando la persona inseriamo i bambini in una miniera di relazioni sane che pian piano faranno il diamante. Il principio personale mette l’io al centro di relazioni che conferiscono identità e si occupa di curarle, mentre quello del risultato spinge a soddisfare gli obiettivi. Gli adolescenti, loro malgrado, finiscono con il mettere in atto proprio l’individualismo a cui sono stati indirizzati, abbiamo detto loro per anni: funziona, concorri, realizzati… anziché ti voglio bene così come sei, vai bene anche quando non funzioni, pensando che dire queste cose fosse pericoloso per la loro «realizzazione» e inadeguato per un mondo in cui merita di vivere solo il più adatto.
Il letto da rifare oggi è allora scrivere il proprio nome al centro di un foglio bianco e collegarlo a tutte le relazioni significative che lo rendono un tu personale, e scoprire grazie a quali collegamenti il nome brilla a prescindere dai risultati, o è in ombra perché prigioniero della morsa degli standard e delle aspettative. Dopo si può fare lo stesso con i nomi delle persone che sono emersi e dipendono dalla relazione con noi, chiedendosi se li amiamo perché ci sono o per ciò che ci aspettiamo e vogliamo da loro. Avremo davanti agli occhi il disegno della nostra «realizzazione» vera (gioia) o presunta (insoddisfazione). Penso ai miei alunni che faranno la maturità, e mi rendo conto che in questi anni si sono «realizzati» di più, come studenti e come persone, solo quando sono riuscito a mettere i loro volti prima dei loro voti. E sui voti non ho mai fatto sconti…
Corriere della Sera, 4 febbraio 2019 – Link all’articolo e ai precedenti

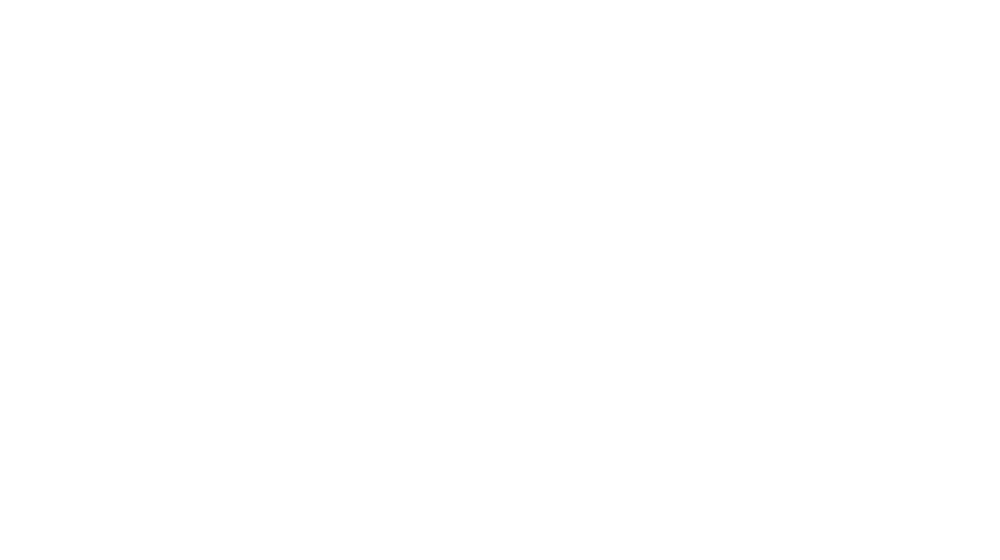
Buon giorno Alessandro, sono formatore presso il centro professionale salesiano di San Donà di Piave. Le materie a cui cerco di far appassionare i miei allievi sono italiano, storia e diritto e con quale fatica! Per fortuna trovo sempre corrispondenza nella sua rubrica settimanale che mi offre l’opportunità di riflettere su chi sono, come sono e come sono con i miei allievi. Io li adoro nelle loro difficoltà, nel loro pressappochismo e nella loro infinita umanità. I loro volti sono tutti impressi nel mio cuore e sono sempre più convinta che valgono tanto, tanto di più di qualsiasi voto meritino!