Il Gioco del Mondo in quattro puntate (I-II-III-IV)
Vi racconto il Presepe in quattro puntate, pubblicate ogni domenica, trascritte qui dalla più alla meno recente.
IV. Il fuoco dello zio
Tra i personaggi del presepe della tradizione siciliana che ho raccontato in queste settimane, quello che mi affascina di più in questa notte di veglia è Zu Innaru, zio Gennaio o Gennaietto. Si tratta di un vecchio pastore, che riscalda il suo corpo infreddolito al fuoco, che poi offre anche a Maria e Giuseppe, perché possano riscaldare il Bambino.
Per quanta simpatia mi abbiano sempre ispirato bue e asino, non mi ha mai convinto la versione idilliaca che fosse il loro fiato a riscaldare il Bambino: più che un conforto sarebbe stato un supplizio, che Maria non avrebbe permesso. Era necessario il fuoco e questo fuoco, nell’immaginazione di chi fa il Gioco del Mondo che è il Presepe, è procurato da un “inutile” (credo che lui così si sentisse) vecchio che porta il nome del primo mese dell’anno, il primo mese del primo anno dell’era cristiana.
Lo Zio Gennaio è un pastore provato da fatica, anni e freddo. I pastori sono disprezzati nel mondo ebraico, a causa del loro lavoro che li tiene lontani dai riti della legge. Gli è rimasto solo il fuoco in questa notte di stelle a riscaldargli un po’ il cuore e le membra, chissà dove è sua moglie e i suoi figli, chissà se si ricordano ancora di lui. Sogna a tratti di palazzi confortevoli e giacigli morbidi, di sorrisi e di abbracci, ma quando si sveglia e vede il suo gregge sente tutta la fatica della sua vita ripetitiva e votata solo a finire, e cerca di riaddormentarsi in fretta, dopo aver attizzato il fuoco, per lenire almeno il gelo del corpo se non quello del cuore. Ma all’improvviso una coppia in cerca di riparo con una giovane ragazza incinta scuote il suo torpore, e offre ad un ragazzo forte e stanco, di nome Giuseppe, il suo fuoco per riscaldare l’ambiente inospitale di uno di quei ripari per animali scavati nella roccia, che lui conosce bene.
Il fuoco è ciò che nel mito Prometeo aveva strappato agli dei, ribellatosi a Zeus, che, deluso dalla razza umana, aveva deciso di sterminarla e sostituirla. Prometeo invece lo dona agli uomini insieme a tutte le arti, proprio perché possano affrancarsi dal controllo degli dei. Per questo Zeus lo condanna al terribile supplizio: incatena Prometeo ad una rupe e il suo fegato, nel mondo antico organo deputato a raccogliere il sangue e quindi la vita stessa, viene divorato dall’aquila del padre degli dei, per ricrescere il giorno dopo ed essere nuovamente distrutto, provocando una continua morte in vita. Gli dei non sopportano che agli uomini vengano concessi i privilegi esclusivi del mondo divino, né che gli uomini siano liberi.
Al contrario, nel Presepe non ci sono divinità invidiose, ma c’è un Bambino che è il Salvatore. Almeno così affermano gli angeli ai pastori, che chiedono un segno. Lo potranno riconoscere così: è in una mangiatoia. Il segno perché Dio si faccia riconoscere è di fatto un “non segno”: la vita quotidianissima di una giovane famiglia in stato d’emergenza, un Bambino deposto in fasce in un presepe. Il segno di Dio è l’ordinario, un segno tenue come la brezza in cui Elia riconobbe la presenza del Signore, che non era in nulla di eclatante. Con questo segno silenzioso e invisibile, una famiglia qualsiasi in un luogo qualsiasi, è abbattuta la separazione tra sacro e profano, il profano anzi diventa il luogo del sacro e del mistero, purché si abbiano occhi per vedere. L’ordinario è divenuto straordinario, Dio si è fatto uomo, adesso l’uomo può farsi Dio. Dio si è fatto Bambino e in una sola notte i Bambini diventano la vetta della dignità umana, quando nella lingua della grande cultura occidentale, il greco, la lingua dei vangeli, i bambini sono indicati solo con l’articolo che si usa per le cose. A differenza degli dei antichi, che ci tenevano alla loro separazione, questo Bambino-Dio non ha neanche il privilegio del fuoco, viene al freddo di una notte di stelle, in un riparo improvvisato, perché nella locanda non c’è posto. Dio non solo non si tiene il fuoco per sé, ma non lo ha e lo deve mendicare all’uomo, dall’ultimo degli uomini: la situazione è ribaltata. Per questo lo zio Gennaio è il mio eroe, perché non è un titano che inveisce contro il cielo, ma un povero pastore infreddolito e disperato, che presta il suo fuoco perché non ha altro. Non sa che sta prestando il suo fuoco a Dio, ma Dio lo sa.
La scena ricorda le parole di uno dei personaggi di Vita e Destino di V.Grossman, Ikonnikov, che riferendosi alla disfatta di nazismo e comunismo, distingue il Bene con la maiuscola che le ideologie degli uomini vogliono imporre con i loro mezzi e si trasforma in sangue, soprattutto di vecchi e bambini, dal bene piccolo e quotidiano: “E dunque oltre al bene grande e minaccioso esiste la bontà di tutti i giorni. La bontà della vecchia che porta un pezzo di pane a un prigioniero, la bontà del soldato che fa bere dalla sua borraccia un nemico ferito, la bontà della gioventù che ha pietà della vecchiaia, la bontà del contadino che nasconde un vecchio ebreo nel fienile. La bontà delle guardie che, a rischio della propria libertà, fanno avere a mogli e madri le lettere dei prigionieri. È la bontà dell’uomo per l’altro uomo, una bontà senza testimoni, piccola, senza grandi teorie. La bontà illogica, potremmo chiamarla.”
Credo sia questa la rivoluzione silenziosa cominciata in questa notte, quella della “bontà illogica”, che porta ad amare persino il nemico e a pregare per il persecutore. Lo zio Gennaio è il primo uomo a ricevere la grazia divina di poter donare (restituire) quel poco che ha a Dio stesso. Egli non lo sa, ma quel gesto senza testimoni fatto ad un “piccolo”, lo ha fatto, lui pastore reietto ed escluso da Dio e dagli uomini, al Dio onnipotente, creatore e signore del cielo e della terra.
Lo zio Gennaio si sente finalmente utile: qualcuno ha bisogno di lui. Dio ha bisogno di lui, con il suo fuoco e con le sue arti, tanto disprezzate da tutti. Al contrario di Prometeo non deve strapparle agli dei invidiosi ma, può donarle al Dio che glieli chiede in elemosina per fare la redenzione, che è rendere evidente agli uomini la verità. Il fuoco che il Bambino ci chiede è quello dei nostri talenti, del nostro lavoro, di ciò che ci riesce bene, di ciò che ci appassiona e ci permette di fiorire e far fiorire gli altri servendoli con quei doni, fino a poter dire che questa vita, nonostante tutto, è bella e vale la pena esserci anziché no. Questo pensa zio Gennaio in quella grotta.
Questo è il mistero della notte di Natale: Dio ha bisogno di te e me. Fosse anche solo per il nostro piccolo fuoco e la nostra grande stanchezza.
III. Artigiani e suonatori
Nelle precedenti puntate sul Presepe si è parlato di pastori, come è giusto che sia. Il Vangelo parla di pastori: a loro viene dato l’annuncio, perché sono loro a popolare i notturni ripari dove si rifugiano Giuseppe e Maria per il parto. Eppure sin da bambino ero affascinato da un presepe affollato di altre due categorie di personaggi: Artigiani e Suonatori, mutevoli a seconda della latitudine. Tra i primi si possono annoverare: fabbri, arrotini, lavandaie, portatrici di uova, acquaioli, carrettieri, venditori di frutta, marinai, facchini, osti e avventori, venditori di caldarroste, vasai, mugnai, tessitrici, filatrici, fornaie, ciabattini, falegnami, cenciaioli, guardiane d’oche, pescatori… Tra i suonatori troviamo: flautisti, zampognari, cantastorie, giocolieri, danzatori…
Questi personaggi non potevano certo essere attivi nel cuore della notte della nascita del Bambino, ma è stato da subito chiaro, a chi inventava il gioco del Mondo del presepe, che non c’è Mondo senza lavoratori e suonatori. Il Mondo in cui Cristo viene non può essere senza lavoro (egli stesso fu falegname per trent’anni) e senza musica. Festa e lavoro sono il ritmo secondo il quale si muove il Recinto del Mondo, il Presepe della Storia umana, come nella prima settimana della creazione.
Inoltre l’uomo è posto da Dio nel giardino dell’Eden perché “lo lavori e lo custodisca” si dice nella Genesi (2,15). Il creato è lo spazio che l’uomo, con la sua creatività, è chiamato a lavorare e custodire, e nel farlo festeggia, riposa, gioisce ed entra in rapporto con Dio, “che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno” con l’uomo (Gn 3, 8). Con il peccato la consegna non è cambiata, è cambiata la risposta del creato: il peccato non introduce il lavoro nel piano divino, che c’era già, ma la fatica e la resistenza del creato e dell’uomo stesso a svilupparsi secondo il progetto di Dio. La dimensione di festa si offusca, Dio non passeggia più con l’uomo, tutto è fatica.
Platone, attento testimone di queste conseguenze, scrive che gli dei condannarono l’uomo al lavoro e per compassione gli concessero intervalli di riposo per le feste, affinché l’uomo ricevesse in quelle occasioni la luce e la forza per vivere rettamente. Per gli antichi la festa era una specie di condono alla condanna quotidiana del lavoro. Riconoscono nella festa la luce originaria, ma non scorgono più il legame divino tra lavoro e uomo, schiacciati solo dal negativo della caduta: la fatica, la ripetitività, la necessità. L’aspirazione è poter non lavorare e la festa serve a costringere gli dei a passeggiare di nuovo con gli uomini.
Con l’incarnazione il progetto divino è restituito al suo ordine originario che dà la possibilità di far festa nel quotidiano, benché sia diventato faticoso (Cristo non ci nasconde che “ogni giorno ha la sua fatica”). Ma che il Dio fatto carne abbia avuto un lavoro e lo abbia svolto per trent’anni elimina ogni ombra di condanna dal lavoro umano. Cristo era noto come falegname e chissà quanto legno avrà piallato nella sua vita, e quel legno, resistente e modellato a fatica e con il quale l’uomo gli modellerà la croce, è stato “redentivo” quanto i suoi gesti straordinari: miracoli, guarigioni, trasfigurazioni. I trent’anni di vita ordinaria di Cristo ci aiutano a rientrare nel piano originario di Dio: il lavoro – purché onesto – non è condanna, ma progetto divino, e la festa, dopo il peccato originale, è ratifica del fatto che verrà un tempo, qui solo intravisto e pregustato, in cui celebreremo in un’unica ininterrotta festa i doni del creato. Senza la festa il lavoro non si comprende e viceversa.
L’uomo per dialogare con Dio è chiamato tutt’ora a coltivare e custodire il pezzo di giardino che gli è affidato. Lavorare è pro-creare: partecipare allo sviluppo e alla custodia delle risorse che gli sono date, infatti l’uomo e la donna, che lavorano nel posto giusto, vedono e sentono fiorire le proprie qualità e quelle di chi beneficia del loro lavoro, nonostante la fatica. Gioioso è solo chi lavorando riposa o riposa lavorando.
Il tempo libero (come ahimè anche i cristiani si sono abituati a chiamarlo, accettando la dinamica della schiavitù al lavoro, come la intendevano i pagani) è in realtà tempo della festa, tempo in cui si festeggia la gioia del talento ricevuto. Invece un lavoro vissuto senza la luce dell’incarnazione, tende a ridursi a condanna, semplice neg-otium, rispetto all’otium degli dei; e il tempo libero finisce con l’essere inteso come “privo di lavoro”, quando è libero ogni istante, feriale o festivo, vissuto da un cuore liberato dalla grazia. Solo se il lavoro è luogo della coltivazione di sé e dono dei propri talenti agli altri, il tempo in cui l’uomo non lavora diventa tempo della festa, priva, questo sì, dall’affanno dell’utile, ma pura gioia del ricevere e del condividere, del ritemprare le forze per un lavoro rinnovato, e non fuga dalla realtà in non-luoghi come gli affollati ipermercati domenicali, versione secolarizzata e insoddisfacente della festa (non mantengono mai ciò che promettono).
L’uomo è chiamato a creare la propria bellezza. Non è già tutta fatta, ma da compiere, in sé e nelle cose: il termine creatura infatti origina dal participio futuro latino ed esprime la tensione verso un compimento di ciò che è già in potenza, come avventura, che è la vita del cristiano, non da salotto, non da divano, non bigotto, ma l’avventura dell’artigiano e del suonatore. È necessario riportare il fuoco nel grigiore del quotidiano, e questo passa solo attraverso quell’arte del vivere che Cristo è venuto a insegnarci con la sua incarnazione e a rendere a noi possibile, donandoci la sua grazia.
Per questo quando il Bambino nasce si dispiega il ventaglio del lavoro dell’uomo e in contemporanea il ventaglio della festa, perché sono due atteggiamenti del cuore, compresenti da quando Cristo è uomo, e ogni giorno possibili, perché è vero che ogni giorno ha la sua pena, ma è altrettanto vero che l’uomo Dio ha conosciuto questa pena e l’ha trasformata da dentro in materia divina (“senza me non potete fare nulla”, anzi si potrebbe dire senza di me “fate il nulla”). Dio ha ripreso a passeggiare con l’uomo, che può finalmente essere artigiano e suonatore nel Presepe del Mondo, in questa notte di stelle.
Avvenire, 20 dicembre 2015 – link all’articolo
II. Il pastore addormentato e quello spaventato
Il Presepe è il Mondo. Dio fece il Presepe del Mondo perché suo Figlio un giorno vi abitasse. L’uomo creando il presepe, ricrea se stesso e scopre l’essenza di quel mondo che è chiamato ad abitare, coltivandolo e custodendolo. Lo sapeva bene Giuseppe Antonio Matera, grande scultore di presepi e pastori del barocco siciliano, inventore di personaggi che entrarono nella tradizione del presepe locale. Se nella scorsa puntata ho parlato del muschio e del pastore che si toglie la spina dal piede, adesso vorrei soffermarmi su altri due pastori del presepe siciliano, posto che nei personaggi del presepe è l’uomo di tutti i tempi che si rivela, con i suoi pregi e i suoi difetti. Così troviamo adagiato da qualche parte il pastore addormentato, detto “Susi Pasturi” (susirisi è il verbo siciliano che indica lo svegliarsi e levarsi), e ben dritto da qualche altra il cosiddetto “Sbaundatu/Scantatu ra stidda”, il pastore a bocca aperta che guarda o indica la Stella, colto da una meraviglia incontenibile (in altre tradizioni è un personaggio femminile di nome Meraviglia).
Mi piace pensare a questi due personaggi come ad uno solo, colto in due momenti diversi. Il sonno tranquillo del primo, meritato riposo notturno di chi ha lavorato tutto il giorno e che proprio in quel riposo cerca la cura di una vita spesso piena di dolore, noia, ripetitività, quella che il pastore di Leopardi conosceva bene: “Se tu parlar sapessi, io chiederei: / Dimmi: perché giacendo /A bell’agio, ozioso, / S’appaga ogni animale; / Me, s’io giaccio in riposo, il tedio assale?”. Il pastore dormiente sa che quel riposo non basta mai, gli manca sempre qualcosa capace di riempire di meraviglia la vita, di gioia e di riposo il lavoro stesso, tanto da risolvere il grande enigma dell’esistenza: esiste qualcosa capace di rendere il lavoro riposo, la fatica gioia, le ore del giorno pace? Quel pastore ci rappresenta quando vorremmo fuggire dall’agone del mondo che si è fatto troppo arduo, quando nel cuore non c’è pace, l’amore degli altri non ci raggiunge, e ci sentiamo soli anche in mezzo alla folla. Gli altri ci toccano, ma la nostra parte più intima non è toccata dalla grazia, dalla bellezza, dalla gioia. Meglio dormire e aspettare il sonno eterno (poi stanco si riposa in su la sera: / Altro mai non ispera, rincara Leopardi), morire o dormire? Entrambe sono esperienze che si fanno in orizzontale, dormire ci prepara alla posizione definitiva. Eppure nella notte oscura del nostro cuore, della nostra vita quotidiana può levarsi una stella, una novità, una notizia che rinnova tutto, che accende una speranza dentro la paura. Ai primordi della letteratura occidentale Omero ci regala una delle sue più belle similitudini, che sembrano descrivere il nostro pastore “spaventato”, “meravigliato”, dalle stelle: “come quando le stelle nel cielo, intorno alla luna che splende, / appaiono in pieno fulgore, mentre l’aria è senza vento; / e si profilano tutte le rupi e le cime dei colli e le valli; / e uno spazio immenso si apre sotto la volta del cielo, / e si vedono tutte le stelle, e gioisce il pastore in cuor suo” (Iliade, VIII, 555-560). Il pastore trova un motivo per essere verticale, attraverso la gioia del cuore, provocata dalla meraviglia del dispiegarsi del firmamento, si sente chiamato ad essere verticale, c’è una forza di gravità che spinge al contrario, chiama verso l’alto, riempe di bellezza la fatica quotidiana. Non è forse quello che Dio fa sperimentare ad Abramo, quando lo invita ad uscire dalla sua tenda per mettersi in viaggio, gli dice: “Esci fuori, guarda il cielo”. La sua discendenza sarà superiore al numero delle stelle. Abramo viene risvegliato dal suo sonno, dal suo ristretto giro di cose e chiamato ad una pienezza nuova, a testimonianza del quale Dio gli mostra il cielo stellato, nulla più (E quando miro in cielo arder le stelle; /Dico fra me pensando: /A che tante facelle?). Allora il pastore Abramo si mette in viaggio, la volta celeste lo invita al volo, non folle e non frutto di semplice immaginazione: “Forse s’avess’io l’ale / Da volar su le nubi, / E noverar le stelle ad una ad una… / Più felice sarei, dolce mia greggia, / Più felice sarei, candida luna.” Quel “forse” viene messo da parte e si fa certezza, il pastore si sveglia e veglia, attende qualcosa e diventa attento, attenzione e attesa hanno la stessa radice, si mette in cerca dei segnali che facciano scoprire l’antidoto al tedio, alla noia, alla fatica, che diano senso anche alla fatica, alla noia e al tedio. La vita del pastore è rinnovata da dentro e costantemente, il piccolo diventa immenso.
Se il Natale non desta in noi questa meraviglia rimarremo dormienti come Susi Pasturi, non ci renderemo conto di nulla e rimarremo chiusi nel nostro ristretto giro di cose, che poi si rovinano e finiscono con l’annoiarci. Eppure sappiamo quanto si parli di necessità di “vegliare” nel Vangelo, sembra quasi essere l’invito più pressante, tra vergini stolte, servi addormentati o pigri, discepoli oppressi dal sonno. L’avvento è l’annuale occasione che ci è data per scoprire il segreto delle stelle, vero fondamento (firmamento vuol dire questo) della gioia stabile del cuore, promessa scritta nelle cose: c’è una Stella in arrivo, per cui vale la pena essere verticali. E riposare è necessario solo per essere più pronti al cammino del giorno dopo. Camminare e riposare saranno un unico gesto festivo, e la ferita della noia, del tedio, della paura, della stanchezza, si rimarginerà poco a poco, grazie alla Stella. E sapere definitivamente che non “è funesto a chi nasce il dì natale”.
Avvenire, 13 dicembre 2015 – link all’articolo
I. Il muschio e il pastore che si toglie la spina dal piede
I santi hanno sempre risolto plasticamente un problema: saldare umano e divino. Imitatori di Cristo, perfetto Dio e perfetto uomo, riuscirono nella loro vita a ripresentare quell’equilibrio tra cielo e terra, tra spirito e corpo, tra mani e pensieri, che risolvono tutte le crisi umane. Così Francesco, otto secoli fa, inventava il presepe proprio per unire spirito e corpo e fare memoria viva del mistero dell’incarnazione. Dio era venuto in un recinto, presepe vuol dire ciò che ha dinnanzi (prae-) un recinto, siepe (-sepes): la mangiatoia. Dio viene nel Recinto del Mondo, confina il suo infinito ed eterno fino a sfinirlo, per concedere allo spazio e al tempo finiti di superarsi e trascendersi, dalle stelle alla stalla e ritorno. La teologia esistenziale di Francesco rendeva permeabile ai sensi dei suoi contemporanei ciò che dodici secoli prima Dio aveva reso permeabile, una volta per tutte, agli uomini di tutti i tempi, incarnandosi: facendo il presepe, Francesco ripeteva l’iniziativa di Dio, facendo risuonare in un piccolo spazio della sua terra quello che Dio aveva fatto venendo nel piccolo spazio della sua Terra.
Il rito del presepe è infatti un rito di ri-creazione: dà gioia e materialmente rifà la storia della salvezza, facendola uscire dalle mani dell’uomo. Nella mia terra, la Sicilia (Terra di Meraviglie e non solo di altre “M” come sostenuto recentemente da alcuni) ci furono le mani di un uomo, nel 1600, che si dedicarono all’attività di scultore proprio per questa ri-creazione: Giovanni Antonio Matera, operante tra Trapani e Palermo, soprannominato dai suoi concittadini Mastru Giuvanni lu Pasturaru, scolpì presepi e soprattutto pastori, che in miniature di 20-30 centimentri confinavano nell’arte scultorea del barocco siciliano l’essenza del mondo. Ne rimase impressionato persino il principe Ludovico di Baviera che, nel suo viaggio in Sicilia a inizio ‘800, fece incetta di quei pastori, pezzi unici, tanto che il figlio Massimiliano II li collocò nel Museo Nazionale di Baviera.
Anche io quando ero bambino sperimentavo questa forza “ricreativa” nel fare il Presepe. Era il rito che scandiva il nostro avvento (lo spirito ha bisogno della materia), all’inizio del quale i nostri genitori ci portavano in escursione in montagna, alla ricerca del muschio fresco nel bosco di San Martino delle Scale. Bisognava essere attenti a scovare i tappeti di muschio più ampi, così da averne pochi pezzi compatti, che rendevano il Presepe più bello. Dovevamo aver cura di staccarlo, meglio dalle rocce che dagli alberi, senza rovinarlo, scegliendo quello con meno terriccio. Poi veniva il rito della pulitura e dell’essiccazione. Solo allora poteva stenderlo sulla base di polistirolo coperta di giornali e cominciare la creazione di quel mondo in miniatura, in cui era rappresentato il gioco che Dio fece col Mondo alle origini, sapendo che sarebbe stato il recinto dentro cui avrebbe giocato il Verbo fatto Bambino. La Creazione non era altro che Il Presepe, la camera del Bambino. E qui la storia di quello scultore siciliano del 1600 si intreccia con la mia, perché mentre il muschio si asciugava andavamo a comprare un pastore nuovo. Erano pastori grandi, tra i venti e i trenta centimetri, di legno. Ogni anno, dato il costo, ne compravamo solo uno nuovo, da un artigiano che si dedicava soltanto a questo (ora non esiste più). I pastori imitavano quelli della tradizione siciliana, tra i quali quelli inventati da Matera, che scolpiva su legno di tiglio le parti del corpo e lo scheletro, sul quale sovrapponeva, con la tecnica della “tela e colla”, vesti e oggetti caratterizzanti il personaggio.
Per me, bambino dotato di grande fantasia, era un vero e proprio avvento: costruivamo il mondo da capo, perché il Natale accadesse, mescolando gli elementi vivi del creato, come il muschio, a quelli verosimili dell’arte umana, le statue del Presepe. Tutto si indirizzava verso una perfetta sintesi.
Uno dei pastori inventati da Matera era il “pastore che si toglie la spina dal piede”, nel quale mescolava l’eco colta dello Spinario di età ellenistica e il gesto realistico del pastore che, recandosi di corsa verso la Grotta dell’Annuncio, si ferisce proprio su quel terreno che imitavamo con il muschio ancora fresco e profumato. Vorrei dedicare questa prima puntata narrativa sul presepe proprio a questo personaggio e al muschio. Il creato è una delle due strade – l’altra è la Scrittura – che Dio ha battuto per farsi trovare, qualcosa che già il mondo pagano sapeva, come testimonia la risposta di Aristotele a quel tale che gli chiedeva dove avesse imparato le verità che spiegava: “Nelle cose, poiché esse non mentono”. La terra non mente, il muschio non mente (indica sempre il Nord, perché cresce sulla parte più umida e fresca degli alberi). Il pastore che si toglie la spina lo sa: la strada per raggiungere la grotta è il Creato, da contemplare, conoscere, coltivare, custodire. Ma quel creato sa anche difendersi, irto di spine, resiste alla trasformazione e coltivazione, soprattutto se sconsiderate, o addirittura può irretire con i suoi rovi, ferire fino ad avvelenare. Per questo, come quel pastore, proprio mettendosi in cammino d’avvento, si sentirà l’urgere della spina che ferisce la nostra carne, che ci ricorda che la nostra umanità è fragile e che per accostarci dobbiamo prima voler eliminare la spina che ci affligge, mostrare la ferita perché venga curata. Le spine estirpate verranno tutte raccolte e intrecciate per una corona regale, il nostro dono al Re che viene come Bambino, la Corona che ha voluto accettare, perché quel pastore, tu e io, diventassimo Re.
Avvenire, 6 dicembre 2015 – link all’articolo


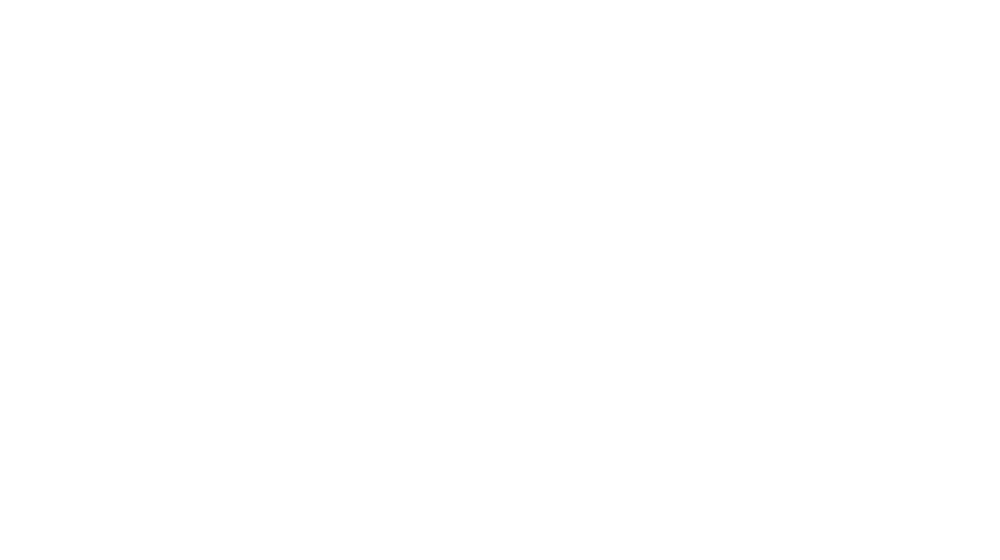
La nostra umanità fragile e ferita si accosta con adorazione e stupore alla fragilità del Bimbo Divino.
“Se in Te semplicità non fosse, come
t’accadrebbe il miracolo
di questa notte lucente? Quel Dio,
vedi, che sopra i popoli tuonava
si fa mansueto e viene al mondo in Te.
Più grande, forse, lo avevi pensato?
Se mediti grandezza: ogni misura umana
dritto attraversa ed annienta
l’inflessibile fato di Lui. Simili
vie neppure le stelle
hanno…” (Rilke)